mercoledì 19 settembre 2007
flagelli divini - Nuova dichiarazione dott.ssa Bortolazzi - PdRC
segnalata dal sito Sassuolo 2000
Data: 18-09-2007 ~ 18:58
Argomento: Politica
Riportiamo la dichiarazione di Donatella Bortolazzi, capogruppo del PDCI all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna, sugli ultimi sviluppi riguardanti la costruzione della moschea di Bologna.
“Assume toni sempre più preoccupanti il dibattito attorno alla realizzazione della nuova moschea di Bologna. Non mi convincono l’azzeramento degli atti e la revoca della delibera decisi dall’amministrazione comunale: non vorrei che dietro una decisione di questo genere, che al di là delle dichiarazioni odora di ripensamento, si celasse un cedimento nei confronti della Curia e di tutti coloro che in queste settimane hanno incitato all’odio e al razzismo nei confronti di una comunità islamica pacifica e ben inserita come quella bolognese. Il diritto ad avere un luogo di preghiera è sancito dalla nostra Costituzione, che specifica anche come tutte le religioni abbiano uguale diritto di cittadinanza sul suolo del nostro Paese, senza distinzioni o discriminazioni di sorta. Spero veramente che la decisione definitiva della Giunta non slitti oltre il termine annunciato della fine di ottobre, altrimenti ci troveremmo di fronte ad un tentativo inaccettabile di far cadere il progetto.
Vedo segnali preoccupanti addensarsi anche sulla manifestazione indetta dalle destre per il prossimo 29 settembre: le dichiarazioni di Raisi contro l’Ucoii sono pericolosissime e rischiano di innescare contrapposizioni ancora più feroci tra cittadini bolognesi e comunità islamica, visto che le ‘teste calde’ di cui parla giustamente Parracino sono sicuramente già pronte ad entrare in azione. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento tranne che di incitamenti all’odio o alla provocazione ed ecco perché accolgo con grande soddisfazione la proposta venuta dalle donne dell’associazione Anassim di promuovere un grande incontro cittadino per parlare di pace e convivenza. Se questa giornata ci sarà, ed io mi adopererò perché così possa essere, di certo il mio apporto non verrà meno”.
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
9:08 AM
2
commenti
![]()
Cofferati perde la delibera ma non il vizio - nota ufficiale
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
8:30 AM
0
commenti
![]()
Etichette: Bologna islam moschea costruzione aeronautica oleodotto
martedì 18 settembre 2007
Merola e la giunta perdono la delibera ma non il vizio.
L'ASSESSORE MEROLA ANNUNCIA IL RITIRO DEL SUO PROGETTO PER LA ZONA DEL CAAB MA NON LA SUA INTENZIONE DI CERCARE UN ALTRO TERRENO PER LA COSTRUZIONE DELLA MOSCHEA.
VI RAGGUAGLIEREMO PIU' DETTAGLIATAMENTE NON APPENA AVREMO ALTRE NOTIZIE.
VI INVITIAMO DOMANI AL PILASTRO PER LA CONFERENZA A CUI SARA' PRESENTE ANCHE UN NOTO SCEICCO (si avete letto bene!) CHE PARLERA' DELLE ORIGINI DEI FINANZIAMENTI DIETRO AL PROGETTO DI COSTRUZIONE DELLA MOSCHEA.
Inviatiamo anche i compagni della CGIL perchè possano vedere con i loro occhi, come noi, persone civili ci sediamo senza acredine di fianco a uno sceicco di ben altra religione.
Riccardo Cuor di Leone docet!
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
11:00 PM
0
commenti
![]()
Etichette: Merola Bologna islam moschea costruzione
REFERENDUM BOCCIATO? DI GIA'?
Ecco l'incredibile articolo apparso sul quotidiano il Bologna del 17-09-07
Esprimiamo la nostra totale fiducia nel comitato dei garanti del Comune di Bologna e nel suo presidente,
ci chiediamo invece come mai vengano messe in giro tali affermazioni che parrebbero voler minare la credibilità della serenità di giudizio che verrà espressa il prossimo 27-09-07
da tale comitato.
Confidiamo che il quotidiano il Bologna ci illumini su questo punto.
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
7:00 PM
0
commenti
![]()
Etichette: Referendum bocciatura
L'equivoco è considerare la moschea solo un luogo di culto
incredibile ma vero!
Dal convento domenicano si leva finalmente una voce che ha il coraggio di dire una scomoda verità.
Speriamo solo che tale voce sopravviva alle ire del Sig. Garuti che sicuramente lo taccerrà di razzismo.
pubblicato sul Resto del Carlino del 16-9-07
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
3:03 PM
0
commenti
![]()
Etichette: Bologna islam moschea
L'UCOII chiede elezioni in moschea
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
2:38 PM
0
commenti
![]()
Etichette: stato islam intesa elezioni moschea
Due islamici si convertono: ora rischiano la vita
siamo certi che la CGIL bolognese, tanto solerte nell'attivarsi contro cittadini come noi, onesti e rispettosi delle leggi ma difensori delle proprie radici, vorrà approfondire e verificare la notizia e nel caso risultasse vera, attivarsi con manifestazioni di piazza e nelle fabbriche, contro queste violazioni dei diritti della persona.
Attendiamo una risposta dai responsabili bolognesi della CGIL che provvederemo a pubblicare ben volentieri.
Due islamici si convertono: ora rischiano la vita
di Marino Smiderle
da Padova
Ventidue persone hanno intrapreso un percorso personale che riguarda solo loro stesse e che non dovrebbe finire sulle pagine dei giornali. Un tragitto religioso, che li porterà ad abbracciare la religione cattolica. C'è chi ha deciso di uscire dalla strada dell'ateismo, chi invece abbandona i sentieri dell'animismo, molto numerosi in Africa, e chi si discosta dal protestantesimo. Se l'approdo al catecumenato, come si chiama il percorso che condurrà questi adulti nella comunità della Chiesa cattolica, arriva sulle pagine dei giornali è perché c'è qualcuno che deve fare tutto di nascosto, senza dire nulla a parenti e amici, di sicuro rischiando, e pure tanto: sono quelli che passano dal Corano alla Bibbia e ai Vangeli, da Allah a Dio, dall'islam al cattolicesimo.
Chiedete a quei due (su ventidue) che a Padova, secondo il quotidiano il Mattino, hanno suonato al campanello del vescovo, mons. Antonio Mattiazzo, per poter partecipare al rito dell'iniziazione cristiana. I due sono, erano, musulmani e, oltre a chiedere di poter far parte della comunità cristiana, avrebbero fatto presente al vescovo di Padova di non potersi permettersi il lusso di rivelare ad alcuno la propria decisione, men che meno ai propri familiari più stretti. Del resto, non c'era bisogno di chiedere questo a un sacerdote che segue i dettami previsti dalla chiesa cattolica in materia di conversioni dall'islam: «Assicurare al catecumeno la discrezione circa il suo cammino che sarà conosciuto solo in seno al catecumenato», recita infatti una delle prime raccomandazioni. Non solo. È avvertita pure la necessità di non rivelare il luogo dove questi catecumeni vivono.
E molti hanno letto in questo senso la smentita arrivata dalla diocesi di Padova, seconda la quale «I candidati al catecumenato erano 21, e precisamente di origine albanese, africana, italiana e russa, ma nessuna di queste persone è di matrice protestante o ortodossa, né tantomeno si tratta di islamici».
La cerimonia al Duomo di Padova, comunque, c'è stata ed è stata suggestiva. «Il rito di ammissione al catecumenato non è una consacrazione (riferita espressamente alla vita religiosa e al ministero dell’ordine), ma un rito con cui i candidati esprimono la loro volontà di approdare alla fede cristiana, volontà che viene accolta dal vescovo diocesano - sottolinea la Diocesi di Padova - I candidati una volta espressa la loro volontà di intraprendere il cammino della fede cristiana, sono entrati in chiesa per partecipare alla liturgia della parola».
Ci vuole una forte motivazione interiore, e quindi una convinzione e una fede ferree per cambiare religione; nel caso dei musulmani, poi, la scelta è più forte della paura di morire. Sì, morire, perché non c'è nulla di peggio, per gli islamici, di «tradire» la propria religione, di diventare un infedele. E in questo si nota la stridente differenza del trattamento subito dai cattolici che si convertono all'islam, destinati nel migliore dei casi a diventare delle celebrità, e nel peggiore a vivere una vita tranquilla e normale.
Il caso, come detto, è stato sollevato dal Mattino, che anche aggiunto alcuni particolari della cerimonia, tipo il termine «peccatori convertiti» usato dal vescovo per definire i catecumeni ammessi all'ingresso della chiesa cattolica. Per arrivare in fondo, per prendere tutti i sacramenti, i ventidue accolti da mons. Mattiazzo dovranno aspettare almeno due anni.
Ma la stessa chiesa cattolica non parla volentieri dell'argomento conversioni, e non fornisce cifre ufficiali per paura di essere «accusata» di far proselitismo. Gran parte dei convertiti dall'islam al cattolicesimo sono comunque albanesi, che sono anche quelli che rischiano di meno in virtù della tribolata storia del loro paese ateo e comunista. Corrono seri pericoli, invece, i maghrebini, gli arabi, i pakistani. Per loro «lasciare l'islam è tradire la comunità». E questa scelta potrebbe valere una condanna a morte.
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
2:17 PM
0
commenti
![]()
Etichette: islam conversione cattolicesimo vita rischio
Ida Magli - Islam stupida ingenuità UE
pubblicato sul quotidiano la Padania del 31-08-07
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
1:15 PM
0
commenti
![]()
Etichette: Magli Ida islam
Cristiano “blasfemo” libero dopo un anno: era innocente
a quando il primo analogo caso italiano?
pubblicato su AsiaNews
Cristiano “blasfemo” libero dopo un anno: era innocente
Qaiser Felix
Shahid Masih, 18 anni, era in carcere dal settembre del 2006 con l’accusa di blasfemia contro l'Islam. Assolto anche il presunto complice, musulmano, liberato su cauzione nove mesi fa. La madre del cristiano è morta di dolore dopo l’arresto.

Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
11:44 AM
0
commenti
![]()
Etichette: islam blasfemia cristiano innocente
La spiritualità dell'antica liturgia
The Spirituality of the Ancient Liturgy
by Father Chad Ripperger, F.S.S.P. - Summer 2001
First of two parts
Among liturgists and theologians, it is generally considered true that each form of ritual embodies a kind of spirituality which is proper to that ritual. Thus, for example, the Eastern rites tend to emphasize the mysterious aspects of the spiritual life as well as the role of icons in promoting devotion to Our Lord, Our Lady and the saints. The ancient rite of Mass embodies a spirituality and spiritual lessons that can appeal to every generation and time. By ancient ritual is meant that rite which was codified by St. Gregory the Great and which underwent a very slow organic development over the course of centuries. The last missal promulgated that enjoys that organic growth is that of 1962.
It is the common perception in the Church today that the liturgical development of the medieval period was, in fact, decadent and that we must return to the apostolic and early Church period in order to know what real liturgy is as well as God’s will regarding the liturgy. This is, however, a fundamentally flawed notion. Aside from the fact that modern liturgical experts (and by modern I mean of the last 100 years or so) were not accurate in their understanding of the liturgies of the early Church, the notion that medieval liturgical development was somehow an aberration is really a rejection of what was an authentic development based upon the understanding of the Mass as sacrifice. Moreover, such figures like to harken back to an era when the liturgy was supposedly “pristine,” by which they usually mean that it conformed to their faulty theology of the Mass as a meal.
The point here is not to give a history lesson, but to explain that one of the premises on which this essay is based is that the ancient rite of Mass is actually the product of the hand of God Who used saints throughout history to develop it according to His holy intention. The desire to reject our liturgical patrimony seems to me to be in fact a desire to reject those things which God has done. Insofar as it is the work of God and the saints, the liturgy embodies certain spiritual principles in the very nature of the ritual that are worthy of reflection. Obviously, we cannot exhaust them all, so we shall limit the discussion to four: 1) the awareness of our sinfulness, 2) the need for self-denial, 3) perfection in virtue and 4) certain aspects about prayer. All of these are essential elements of any sound spiritual life.
I. Awareness of Sin
The first is, again, an awareness of our own sinfulness. The ancient rite of Mass starts with the prayers at the foot of the altar, which begins the Mass with the priest orienting himself to the altar – the altar of his youth. The altar is, of course, the place where the sacrifice for our sins takes place, and the priest asks God to judge his cause. Immediately, there is a clear understanding that there are good and bad in this world. Since the Confiteor is required in every Mass, the ancient ritual makes it clear to us that we have sinned and the priest, and later the people, confess their sins not only to God but also to the whole heavenly court – i.e., to specific saints as well as to all the saints in general. The priest himself must confess his sinfulness independently of the people, both as an example for them and a sign that the priest needs to be keenly aware of his own personal sinfulness. The priest asks to be washed and forgiven repeatedly throughout the ritual in order to foster a sense of humility and unworthiness before God to perform the function that belongs to him. No priest who takes the prayers seriously can be overcome with pride. As the priest ascends to the altar, he asks for the sins of the people to be taken away and then as he reverences the altar he asks specifically that all his sins be pardoned.
There is of course the Kyrie, which is an appeal for God’s mercy, and before the Gospel the priest asks again that his heart and lips be cleansed. Aside from the Confiteor, perhaps the most notable recollection for the priest for his sins is contained in the offertory prayer Suscipe, sancte Pater. The priest says during this prayer that he offers the spotless Host to “atone for my innumerable sins, offenses, and negligences.”
It is necessary for the priest to remind himself constantly of his sinfulness and his proclivity to evil so that he will be motivated to root the sin out of his life. It is also necessary for the priest to do this so that he recognizes his unworthiness to offer the sacrifice and the need to strive for purity and holiness in order to offer it worthily. Since the first step toward sanctified perfection is to be aware of and admit to one’s own sinfulness, these prayers are highly important for the spiritual lives of priests. None of us who are aware of the scandals and sins associated with priests over the past forty years should desire that these prayers be taken out of the offertory or Mass. The laity must desire that the priest be sinless, and one of the ways that is facilitated is by recognizing in the prayers at Mass that he is offering this sacrifice not only for the people but also for himself. If a priest has a sensitive conscience and knows that he must remain pure for the sake of offering the sacrifice, then he merits more graces from God for the people. Today people say that as long as the Mass is valid, the state of the priest does not really matter. While it is true that a priest does not have to be in the state of grace to offer the Mass validly, nevertheless, he has an obligation to be as holy as possible in order to merit more for those under his pastoral care.
There are of course two kinds of merit in the Holy Sacrifice of the Mass. The first is Our Lord’s own Sacrifice in which, by the hands of the priest, He is offered to God the Father in expiation for our sins. Here we are referring to the fact that the Mass is the participation in the Sacrifice of Calvary and the merit flowing from this Sacrifice is infinite since That Which is offered is Infinite. But in addition to this essential or primary merit, there is a secondary merit that flows from three things: (1) the holiness of the priest, (2) the holiness of the people who join their own particular sacrifices to the Sacrifice of the priest and (3) the ritual itself. In order for us to gain more fruits from the Mass, we must do everything we can to aid the priest in being holy, e.g., by offering our prayers and mortifications for him so that he will obtain a holiness of life. But this is possible only when the priest is constantly reminded of his ability to fall into sin if he does not rely on the grace of God. It does not help us to ignore this reality and remove it from the ritual. Rather, the awareness of our sinfulness is absolutely necessary for our spiritual advancement, and the ancient ritual is not lacking in this regard.
The word culture comes from the Latin word “cultus.” While our subject does not allow us to go too far into the discussion, we should be aware of the fact that the cult – that is, the liturgy or rituals of the predominant religion – actually determines the culture of the society. We have seen this historically during the Protestant revolts and we have even seen it in our own lifetimes: when the Church changed the ritual of the Mass, the Catholic subculture in this nation collapsed. The point here is that if we want to transform our culture, we must have a ritual that possesses a keen awareness of our sinfulness; if we expect our society to have an awareness of sin, the priest when he approaches the altar must have a sense of his sinfulness. Since all graces come into the world by means of the Catholic Church, if our ritual is deficient, then perhaps we are cheating the world of the graces that the ritual we offer is meant to convey.
II. Self Denial, Detachment and Mortification
The second spiritual aspect of the ancient ritual that is manifest in a number of ways in the old rite is the sense of self-denial and mortification. One of the clearest manifestations of this self-denial is the old rite’s silence. When we meet someone who has the vice of loquacity, of talking too much, it is usually because the person is full of himself. It is a fact of human nature that any time we do something that is in accord with our physical dispositions, we get a certain pleasure from it. People often speak of being in the “mood” for certain things and not others, and when they get the thing that corresponds to their mood, they experience a certain pleasure in it. Talking is much the same way: the appetites can become attached to talking, and this is precisely what the old rite militates against. By requiring the silence of the people, it provides an opportunity for the appetitive desire to talk to be stripped from those in attendance.
I have had many discussions with laity who come to the old rite for the first time and they often find an appetitive revulsion to the ritual because of the silence. They do not express it exactly that way, of course, but as they talk it becomes clear that they do not like the fact that they are not being talked at and not doing some of the talking themselves. St. John of the Cross used to say that before he would enter into mystical contemplation his “house,” as he called himself, became all quiet; and by this he meant that all of his appetites and faculties had quieted down. This is a sign to us that we must be quiet, we must be stripped of self in order to ascend the heights of perfection, and the old Mass aids that understanding. Moreover, it teaches us that we do not have to be the center of attention by talking in order for the ritual to have a deeper meaning and significance.
The old ritual also fosters a sense of detachment on the side of the priest and the people because the ritual is completely determined by Holy Mother the Church. We see in the Old Testament that God gave very detailed instructions on how He was to be worshiped. This is key in understanding the liturgy in two ways. The first is that the liturgy is not our action, it is the action of God by means of the priest; it is not something we do, it is essentially something God does, for the consecration cannot take place without God Who is the first cause of the Sacrifice. The second way is that it is God, and not ourselves, Who determines how we will worship Him. This has been one of the most notable failings in modern times: a desire to determine for ourselves how we will worship God. It is erroneous because it is up to God to tell us the type of worship that pleases or displeases Him and, therefore, only He should be the one to determine the ritual. It was mentioned earlier that God had fashioned the liturgy over the course of time through the saints, who were filled with love of God – everything they did came from Him and led back to Him. The old rite teaches us the important spiritual lesson that if we are going to be holy and pleasing to God, then our task is to conform to the liturgy and not make the liturgy something of our own doing or make it conform to us.
Furthermore, since it is God who must determine the ritual, we learn that the Mass is not about us but about God. We are only a secondary aspect of the rite. This is made clear in the ancient ritual in that control over the liturgy is taken away from us, and we thereby recognize that it is not about us. While our desire is to benefit from the Mass, our benefit ultimately must be referred back to God; that is to say, we become holy because it gives God greater glory. So even the aspects that affect us are ultimately about God.
The traditional rite, by determining how the ritual is to be done, provides two important spiritual benefits for the priest. The first is peace, for he can go and conform himself to the will of God by following the rubrics of the Mass since they are predetermined; as a priest I cannot say what a great sense of freedom this gives. He does not have to fret over what he will choose and say because he is worried about what the congregation may think. He does not have to listen to a liturgical committee trying to tell him what to do. The second is that it teaches the priest self-denial and sometimes mortification when the ritual is out of his hands. The Mass is not about the priest; it does not have to be sustained by his personality. Obviously only a priest can offer the Mass, but he can lose and forget himself when the whole ritual is determined by the Church, which is the Vox Dei, the Voice of God. It makes it possible for him to forget himself and everything else so that he can perfectly enter into the mystery and the sacred realities present, and thereby derive the greatest benefit from them. In a most perfect fashion, he acts in persona Christi – in the person of Christ – because his own personality is minimized and he can become more like Christ. Since he says Mass facing God and not the people, his own personality, or lack thereof, is not what sustains the ritual. He is able to let his own personality fade into the background so that he can concentrate fully on attending to God. Here when we talk of service, the priest serves God first and foremost. Too often when the term “service” is used in conjunction with the priesthood, it usually means some type of social service, rather than its real meaning of service to God.
The old Mass has only two kinds of options, both of which are heavily regulated. The first is that on certain days, according to certain conditions, votive Masses can be said; but that is something exterior to the ritual. The second is that under certain circumstances and on certain days, predetermined optional prayers may be added to the propers, e.g., to pray for rain, for peace, or something of this sort. But these are heavily regulated so that the priest understands that while he may choose to do them, when and how are not entirely up to him. The point is that options within the ritual should be minimized in order to foster obedience to superiors, self-denial and the reduction of self-will, all of which are necessary to the spiritual life. If many options are allowed, it actually militates against the priest’s self-denial and it fosters self-will, since the ritual becomes subject to his choice. It also leaves him with the impression that the liturgy is really his doing rather than an action performed by God through him.
Lack of options teaches the priest detachment and it also teaches the laity self-denial because they know they cannot try to manipulate the priest to do in the liturgy what they want, since it is out of his hands. Detachment is key to any discussion of the liturgy and any sound spiritual life. Modern man has lost all detachment regarding the liturgy and he is constantly subjecting it to his appetites. But we need detachment, and any discussion of liturgical restoration requires that people first detach themselves from what they want so that they can know what God wants. Furthermore, the multitude of options and lack of detachment in the liturgy has led to a type of Immanentism. Immanentism is a philosophy or notion which holds that everything of importance is about us and comes from us. If it is not from us, then it has no meaning or significance. Immanentism comes from the two Latin words in and manere which mean to remain in. Since man is incapable of reaching the heavens on his own (Babel and the Pelagian heresies have clearly demonstrated that), the liturgy must be from God and about God in order to draw us out of ourselves and to foster any sense of the transcendent, the striving for which is deeply rooted in the heart of man.
The ancient liturgy also provides a depth to one’s spiritual life for three reasons. The first is that it takes us out of ourselves and brings us to God; if we remain in ourselves and if we fashion a liturgy that is at our whim and ultimately about us, then we are doomed to shallowness and superficiality. Rather, insofar as the liturgy is out of our hands, we recognize that it is beyond us, it is mysterious, and insofar as it is about God, it can forever be contemplated. The second is that it is founded on tradition. Tradition provides a mechanism in which man can abandon himself to God who fashions the tradition rather than taking control of it himself and jettisoning the tradition. In other words, tradition provides a mechanism by which the spiritual and liturgical patrimony of the saints can be given to each generation, who can use it to their spiritual benefit. Like someone who does not know his historical roots and therefore does not know himself, modern man has chosen to reject liturgical tradition and replace it with himself, only to be lost in self and never truly to understand himself. Tradition provides a way for the young to ground themselves in the wisdom of the past. This applies not only to cultural things but to the liturgy and the spiritual life as well.
The third thing that the ancient liturgy provides is repetition. Now modern man has rejected repetition because he has a fixation on novelty. Novelty, of course, gives our appetites delight but does not necessarily indicate depth. To enter into something in depth requires time and repeated considerations of a thing. Repetitio mater discendi, as we say in Latin: repetition is the mother of learning. This principle applies not only to learning but to our spiritual lives as well. By repeating a prayer, its meaning becomes more known to us and therefore is able to be entered into more perfectly and with greater depth. Since the ancient rite allows not for novelty but repetition, it provides a way in which people can focus on the mysteries present rather than the new things that are constantly popping up. With the silence quieting our faculties and the repetition that characterize each Mass, we are able to participate in and enter more perfectly into the mysteries of the Mass. Too often participation is equated with physical activity rather than the higher and more active form of participation which is spiritual participation.
Novelty begets spiritual gluttony. By spiritual gluttony is understood the spiritual defect by which one takes delight and concerns oneself only with the physical and spiritual consolations sent by God rather than using the consolation as a means to growing more holy. Spiritual gluttony occurs when people do spiritual or religious things because of some consolation or delight they derive from them and so the delight, rather than God, becomes the end of the action. Novelty begets spiritual gluttony because people tend to think that newer is always better, and so each new thing brings them some new delight. Here we see that novelty can easily degenerate into keeping people entertained, but the danger is that insofar as it prompts one to stop looking at God and fixating on the new thing that sates our appetites, it impedes our spiritual growth. All of the saintly spiritual writers warn that spiritual gluttony is very dangerous for the spiritual life.
The ancient ritual actually destroys spiritual gluttony on three levels. First, all of the silence takes away from our appetites the desire to talk. It is a fact that some people like vocal prayer because of the “spiritual high,” to use a degenerate sixties and seventies term, that comes from doing the talking. Second, the repetition ensures that the appetites, which constantly want something new, are not satisfied. Repetition in a spiritual good is something that is appreciated on an intellectual level, not an appetitive level. Our appetites can get bored when we experience the same thing; the intellect, on the other hand, is able to see the value of the thing each time it encounters it. Thirdly, a certain pleasure comes from being in control of something. This is another reason that the ritual must be fixed or determined by the Church and not by ourselves. For insofar as the ritual is determined by our choice among options and not according to the universal laws of the Church, we take a certain pleasure in being in control. But this to subordinate a spiritual good to our natural desires.
Moreover, while it is not part of the newer rituals themselves, some of the forms of music employed in them are used because of some sensible or appetitive pleasure derived from the music rather than for their usefulness in drawing the mind and will into closer union with God. This leads people to confuse the pleasurable experience with actually experiencing God. In effect, it leads people to think that authentic experiences of God are always pleasant. While in the next life they are, in this life the experiences of God are often arduous and exceedingly painful for us – not because of some defect in the way God handles us, but because of our imperfections and sinfulness which cause our pain. As St. Theresa of Avila once said, “God, if this is the way you treat your friends, no wonder you have so few of them.”
The point is that music and all of the other aspects of the ritual should be geared toward weaning people off sensible delights and consolations as the mainstay of their spiritual lives. This is why Gregorian chant which, has an appeal to the intellect and will, naturally begets prayer, which is defined as the lifting of the mind and heart to God. Gregorian chant does not appeal to one’s emotions or appetites; rather, the beauty of the chant naturally draws us into contemplation of the divine truths and the mysteries of the ritual.
To return to our discussion of liturgical options, by having a predetermined ritual by the universal laws of the Church, one avoids having one person force his disposition and his own spiritual life or lack thereof on the rest of the people attending Mass. In other words, it avoids having someone impose himself or intrude on the spiritual lives of the laity by the choices he makes which flow from his own interior dispositions and spiritual life. Since people naturally differ in disposition, when the ritual becomes the product of one individual or even a few, it loses its spiritual appeal to the rest of the people, who may not share the same dispositions.
The traditional rite, on the other hand, avoids this pitfall by determining the ritual itself. One of the advantages of the ancient ritual is that it does not matter which parish you attend; it is everywhere the same. Insofar as the options of the new rite allow for the particularization of the ritual, it ceases being catholic (meaning universal). In fact, in an age of hyper-mobility, it seems especially imprudent to have changed the ritual. I realized this when I went to Rome and attended Mass in Italian. Had the Mass been in Latin according to the ancient rite, I would have felt right at home at Mass; instead, I was left with the impression that I was merely an onlooker from the outside. This is why Latin and a fixed ritual allow the Mass to have a universal appeal: one can attend it in every country, in every parish in the world and still feel right at home. While we may not understand the homily or sermon when we are in a foreign country, we can nevertheless enter into the ritual in the same depth and fervor that we can at our home parish. This also avoids the unfortunate problem of people parish shopping, as it were, trying to find a priest whose choice of Mass options suits their own dispositions.
Latin also provides a form of self-denial by taking the translation of the ritual out of the hands of questionable agencies. Inclusive language is a classic example of what we have been describing: the desire of a small group to impose its own spirituality on everyone else. The desire for inclusive language is a manifestation of the expectation that the ritual should conform to the group rather than vice versa. Latin undermines this idea because everyone, as Pope John XXIII says in Veterum Sapientia, is equal before the Latin language. Latin forces a type of self-denial on us because we can not manipulate the language to our own ends. It also thwarts the inclination of the priest to ad lib, foisting his own personal disposition on those attending the Mass.
The Latin, the fixed rubrics, these things strip us of our selves so that we can become nothing. St. John of the Cross often noted that we must be nothing so that God can become everything in us, or, as in the words of St. John the Baptist (which we can apply to the ancient ritual), “I must decrease, so that He may increase.” Stripping ourselves of self, which the ancient ritual does, is a requirement for any authentic spirituality.III. Perfection in Virtue
This brings us to the next topic: perfection in virtue. The old Mass, insofar as it strips us of self, humbles us. This is necessary, since every one of us suffers from pride. Moreover, by not giving us control over the ritual, the old rite begets meekness, the virtue by which one does not go to extremes in one’s reactions or actions. There are countless stories of laity and priests being furious after attending the new rite because of something the celebrant did. The priest should not be the cause of anger during the Mass. By becoming the cause of anger, he erodes the meekness of the laity. Having a fixed ritual, provided the priest follows the rubrics and says the Mass reverently, minimizes the chance that the priest will anger the laity. In this way, the old rite assures meekness.
Humility is the root virtue in the concupiscible appetite, i.e., the thing in us that inclines us toward bodily goods. Humility is the virtue by which one does not judge oneself greater than he is. St. Thomas Aquinas tells us it is the root virtue of all the other virtues and that no other virtue can exist without it. The old Mass roots out pride and begets humility because it is not our action or our product but the product and action of God. Moreover, by coming up against the mysterious which for us in this life is insurmountable, it naturally causes in us a sense of our smallness in comparison to God. This in turn tempers the way we behave because we are in the presence of someone who causes “awe,” which is an overwhelming sense of wonder or admiration. “Awe” naturally causes us to stop and consider ourselves in the light of that which is awesome; it captivates us and therefore moderates what we do. The ancient ritual, in begetting humility and meekness – upon which all the other virtues rest – reminds us of the words of Christ, Who said, “Learn from Me, for I am meek and humble of heart.” In other words, “ I conform myself to the truth, I am not proud and do not judge myself greater than I am, I do not go to extremes in my reactions.” This is what we must desire in any ritual. The ritual should speak to us – not in our own words, but in the words of Christ. In this way the ancient ritual can be seen to be saying metaphorically, “Learn from me, for I am meek and humble of heart.”
Once meekness and humility are in place, the virtue of reverence naturally follows. Reverence is the virtue contained under the more universal virtue of justice, and more particularly religion, in which one holds in honor and esteem some thing, usually sacred. The ancient ritual helps us to honor those things that are holy because, first, we are humble and recognize the greatness of sacred things. Secondly, we approach God in a sense of self-denial and subservience, and in this respect the ancient ritual excels. For the priest bows his head, genuflects and humbles himself often in the prayers that God might look upon his actions and be pleased.
Fortitude is also taught in the ancient ritual, if in no other way than that it is clear that it is spiritual warfare. At the very beginning, when the priest vests by putting on the amice, he says a prayer in which he asks Our Lord for the helmet of salvation so that he can fight off the incursions of the devil. Also, since the priest is not subject to a liturgical committee in making decisions on what should and should not be done, the traditional rite strengthens the priest and reaffirms the masculine aspects of being a priest.
Here we highly recommend the article by Fr. James McLucas on the emasculation of the priesthood, (The Latin Mass, Spring 1998) in which he argues that the newer rituals have, in fact, taken away from the priest those things that are masculine: e.g., the role of providing for and protecting his spiritual family. In the ancient ritual, he alone feeds his spiritual family by distributing Holy Communion. This also means he can protect the sacred mysteries. The systematic removal of all these things that emphasize the masculine and fatherly role of the priest has weakened our vision of the priesthood. Moreover, we tend to get what we offer as an example. Thus, if we place before people a weakened view of the priesthood that has little or no virtue of fortitude, then we can expect priests to become weak and effeminate, and attract seminarians who follow suit. Fortitude is defined as engaging the arduous good and the ancient ritual provides an avenue for the priest to obtain the greatest and most difficult type of fortitude: self-discipline through self-denial.
The ancient ritual also avoids violations of justice. The new Code of Canon Law states that the laity have a right to attend the liturgy said according to the rubrics. Now all the options have eroded the sense that the priest must render to the people their due; the flow of the Mass is at his discretion. This leads the priest to think that he can do whatever he likes. While Church documents are clear that he cannot do so, the fact is that all these options contain the implicit principle of “do what you want.” This is why, when the ritual is out of the hands of the priest, it naturally begets a sense of the requirement of justice in all of us. For when the priest does something that is contrary to the rubrics, or even in the rubrics but included as optional, it gives people a sense that the priest is concerned not so much about what God wants as about what he wants, especially if one attending the Mass does not like the particular option. Ultimately, the ritual of the Mass is about God, and ought to seek the best way of rendering to God His due. This comes through a deep sense of justice. Through the sacrifice to God and the conformity of the ritual to that sacrifice, we recognize that with respect to God, we have no claim of justice insofar as we are mere creatures. Therefore, the Mass must be about God and not ourselves. The ancient ritual helps us to forget and lose ourselves in the rendering of justice to God through the Sacrifice.
The ancient rite begets faith, hope and charity. It begets faith because it excels in its expression of Catholic theology. Faith comes through hearing and we hear the Faith in the very prayers of the ancient ritual. It begets hope because of its deep sense of the transcendent and our participation in the transcendent. It begets charity because it helps us to realize that worship is about God, not us. Charity is defined as love of God and neighbor for the sake of God. Even when we love our neighbor, it must be for the sake of God. Hence the ritual helps us to focus everything on God, thereby giving a proper direction to our spiritual lives. Even if this were not the case, the ancient ritual begets charity if for no other reason than that it keeps people’s imperfections at bay by taking away the ability of one person to impose himself on another, thereby averting anger, hurt feelings and the like.
IV. Ascendance in Prayer
The last aspect is ascendence in prayer. We have already mentioned the silence that is necessary to ascend the heights of prayer. While it is not required for vocal prayer, it is required for mental prayer and the other seven levels of prayer. St. Augustine said that no person can save his soul if he does not pray. Now it is a fact that mental prayer and prayer in general have collapsed among the laity (and the clergy, for that matter) in the past thirty years. It is my own impression that this development actually has to do with the ritual of the Mass. Now in the new rite, everything centers around vocal prayer, and the communal aspects of the prayer are heavily emphasized. This has led people to believe that only those forms of prayer that are vocal and communal have any real value. Consequently, people do not pray on their own any longer.
The ancient ritual, on the other hand, actually fosters a prayer life. The silence during the Mass actually teaches people that they must pray. Either one will get lost in distraction during the ancient ritual or one will pray. The silence and encouragement to pray during the Mass teach people to pray on their own. While, strictly speaking, they are not praying on their own insofar as they should be joining their prayers and sacrifices to the Sacrifice and prayer of the priest, these actions are done interiorly and mentally and so naturally dispose them toward that form of prayer. This is one of the reasons that, after the Mass is said according to the ancient ritual, people are naturally quieter and tend to pray afterwards. If everything is done vocally and out loud, then once the vocal stops, people think it is over. It is very difficult to get people who attend the new rite of Mass to make a proper thanksgiving by praying afterward because their appetites and faculties have habituated them toward talking out loud.
The ancient ritual also gives one a taste of heaven, so to speak. Since the altar marks the dividing line between the profane and sacred, between the heavenly and the earthly, and the priest ascends to the altar to offer Sacrifice, the traditional rite leaves one with a sense of being drawn into heaven with the priest. This feature naturally draws us into prayer and gives the sense of the transcendent and supernatural that are key in the spiritual life. The numerous references to the saints foster devotion rather than minimizing it. The Latin provides a sense of mystery. The beauty of the ritual, the surroundings that naturally flow from the ritual itself (such as the churches that are designed for the ritual), the chant – all of these things lead to contemplation, the seeking after that which is above.
Conclusion
Clearly we have not exhausted all the spiritual aspects of the ancient ritual, but the four areas we covered demonstrate that the ancient ritual and the newer forms have different spiritualities. If the Church is to capture the sense of the transcendent for the laity, if we are to have humble and saintly priests, if we are to have a ritual that is driven by charity and therefore has God as the sole focus of our longings and desires, it must restore that liturgy that God Himself fashioned both when Christ was on earth and through the loving hands of the saints throughout history. We cannot be satisfied with a liturgy that is the work of our own hands. For this reason, I do not subscribe to the theory that we need to produce yet another ritual. We need the work of God back, because if the ancient ritual does anything, it teaches us that we do not need our own self-expression. We need God.
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
11:09 AM
0
commenti
![]()
Etichette: liturgia latino spiritualità
Cattolici sotto processo nell’Africa arabizzata

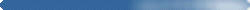
 editoriale
editoriale
guerra di religione in algeria
Cattolici sotto processo
nell’Africa arabizzata
di Ida Magli
il Giornale | 5 Settembre 2007
L’Africa è oggi non soltanto quasi del tutto musulmana, ma anche arabizzata. Questo significa che molti dei caratteri psicologici e culturali che l'Europa conosceva, oggi non esistono più. Il ricordo della storia passata, inoltre, per la maggior parte degli Africani è incancellabile quale che sia la generosità degli aiuti e i rapporti di simpatia che varie nazioni europee, ivi inclusa l'Italia, cercano in tutti i modi di stabilire. Il «tempo» per i musulmani è sempre presente; il concetto di storia che per noi è una forma di «tecnica del divenire», che ci aiuta appunto a far diventare passato ciò che è accaduto, non è neanche pensabile nel mondo coranico, che lo sentirebbe come un tradimento verso Allah.
Naturalmente è proprio questo atteggiamento mentale
che in qualche modo obbliga i musulmani a vivere più o meno come vivevano un millennio e mezzo fa, ma noi dobbiamo convincerci che non abbiamo né il diritto né la possibilità di cambiare il loro modo di pensare e di vivere. La Chiesa deve anch'essa convincersi
che l'universalismo cristiano non si può più realizzare, e
che forse, era perfino sbagliato crederlo anche quando l'impero romano sembrava aver unificato quasi tutto il mondo raggiungibile partendo dal centro dell'Europa.
Ma questa è soltanto una premessa di carattere teorico. La realtà culturale e politica, che pure i governanti sembrano non voler comprendere, è che esiste un Islam che ormai ha già coperto il Medio Oriente e l'Africa e sta penetrando in India e in Cina, congiungendosi in modo da formare l'arco che attraverso l'immigrazione sgretolerà la struttura culturale dell'Europa. Stranamente, invece, l'Europa si comporta come fosse convinta che possa, o meglio che debba avvenire il contrario; ossia che il modello europeo della uguaglianza, della solidarietà, della non violenza, del benessere sarà quello vincente, che tutti vorranno abbracciare. Si tratta di un errore gravissimo, compiuto da politici-economisti, per i quali la libertà del mercato è in assoluto la libertà per gli uomini. E, di conseguenza, la pace, la felicità. È indispensabile, dunque, che l'Europa rimetta i piedi per terra. Che la Chiesa, se vuole sussistere nella sua essenza evangelica, rimetta i piedi per terra. Non diventerà più forte né più credibile riallacciandosi all'Antico Testamento, o cercando le analogie e punti di contatto con Maometto.
I Vangeli sono una realtà unica; Gesù ha combattuto
contro i precetti dell'Antico Testamento, ha messo le donne alla pari con gli uomini; ha gridato con tutte le sue forze che a Dio non servono i sacrifici degli animali, non servono le ripetizioni di preghiere e di gesti sempre uguali. Ma non servono neanche le masse.
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
10:34 AM
0
commenti
![]()
Etichette: Africa islam processo cattolici
Amato sbaglia, con l'islam non si può seguire il modello delle intese
| ||
 | ||
| ||
Il ministro degli Interni Giuliano Amato torna sulla vecchia proposta dell’Intesa con i musulmani: «Serve una intesa con i musulmani - afferma - per poter avere con le loro organizzazioni religiose gli stessi rapporti chiari e trasparenti che ho con le altre a partire dalla Chiesa cattolica».
A prescindere dal fatto che le Intese con le minoranze religiose non hanno lo stesso statuto giuridico e costituzionale del Concordato - giustamente riservato solo alla Chiesa cattolica, di cui i costituenti vollero riconoscere il ruolo unico nella storia e nella cultura italiana -, a prima vista il ragionamento di Amato potrebbe sembrare logico. Ci sono Intese - cioè «piccoli concordati» - con gli Ebrei, i Valdesi, i Battisti, gli Avventisti, i Pentecostali, i Luterani. Prodi ne ha firmate altre, in attesa di ratifica parlamentare, tra gli altri con i Testimoni di Geova. Perché non con i musulmani?
La risposta c’è: perché i musulmani non sono una di quelle «confessioni religiose» che i padri della Costituzione avevano in mente quando formularono l’articolo 8 della nostra Carta fondamentale. Una confessione religiosa è una realtà strutturata, organizzata, gerarchica, dove ci sono delle autorità che rappresentano tutti i fedeli e possono impegnarsi per loro di fronte allo Stato. Vale per i vescovi cattolici, ma anche per il Sinodo valdese o per il presidente dei Testimoni di Geova. L’islam sunnita (quello sciita è diverso, ma in Italia è piccolissimo), detto in termini sociologici, non è una religione verticale, ma orizzontale.
Non ha un clero, non ha l’equivalente dei vescovi, del Papa e nemmeno dei parroci. Gli imam - cui i nostri media, abituati a trattare con la Chiesa cattolica, danno spesso troppa importanza - non sono le guide delle loro comunità, ma semplici incaricati temporanei di guidare la preghiera e gestire il locale di culto. Per stipulare un’Intesa, come è evidente, bisogna essere in due: lo Stato e chi esercita l’autorità nella «confessione religiosa» di cui all’articolo 8 della Costituzione.
L’islam (sunnita) si vanta precisamente di non avere autorità né gerarchie. L’unica autorità è il Corano, e il consenso nella comunità dovrebbe riconoscere l’opinione del più saggio e del più dotto. Di fatto, in molti paesi musulmani anche le questioni religiose sono decise dal re o dal governo: ma l’Italia, appunto, non è un paese musulmano.
Certo, da noi esistono diverse associazioni di musulmani, ognuna delle quali dichiara di essere «quella vera» e vorrebbe firmare l’Intesa. Quella che controlla più moschee, l’UCOII, ha una dirigenza fondamentalista e legata ai Fratelli Musulmani, i cui valori sono incompatibili con la Costituzione. Le associazioni filo-occidentali rappresentano solo una minuscola frazione dei musulmani italiani. La maggioranza degli immigrati non fa parte di nessuna associazione, e spesso non ne conosce neppure il nome. La Consulta per l’islam italiano è stata creata dal predecessore di Amato, Pisanu, come organismo dichiaratamente «non rappresentativo», con membri scelti dal ministro sia tra i responsabili delle associazioni (UCOII compresa) sia tra intellettuali che rappresentano se stessi. Pisanu non voleva certo fondare un’inesistente «Chiesa» islamica, e se la Consulta firmasse un’Intesa molti leader musulmani il giorno dopo la dichiarerebbero carta straccia. Amato si rassegni. Sarebbe certo una bella cosa se questo governo avesse una politica seria dell’islam italiano. Ma la strada non passa dall’Intesa.
Per inviare una e-mail alla redazione del Giornale cliccare sul link sottostante
lettori@ilgiornale.it
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
9:03 AM
0
commenti
![]()
Etichette: islam intese Introvigne
San Marco d'Aviano - una biografia completa
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
7:00 AM
0
commenti
![]()
Etichette: Marco Aviano
lunedì 17 settembre 2007
San Marco d'Aviano - fautore dell'identità Europea
tratto dal sito http://www.internetsv.info/Aviano.html?a B. Marco d'Aviano Beato Marco d'Aviano Cappellano dell'Esercito Imperiale austriaco Marco d'Aviano, venerabile. Nacque ad Aviano (Udine) il 17 nov. 1631 dai distinti coniugi Marco Cristofori e Rosa Zanoni ed ebbe, al Battesimo, il nome di Carlo Domenico. Ricevette la prima istruzione da un precettore del paese e, in età conveniente, i genitori lo affidarono al collegio dei Gesuiti di Gorizia. II ragazzo, di carattere timido ma sognatore, si lasciò prendere dall'entusiasmo e un giorno, al rientro degli allievi da una passeggiata, mancò all'appello: era fuggito per andare a convertire i Turchi. Dopo due giorni di cammino batté spossato alla porta dei Cappuccini di Capodistria. La crisi giovanile si risolse con la chiamata di Dio al chiostro e, il 21 novembre 1648, egli vestí l'abito nel noviziato di Conegliano, mutando il nome di Battesimo in quello di Marco. Dovette vincere alcune difficoltà; tra l'altro, i superiori, in un primo tempo, non pensavano di ammetterlo allo studio. Fu l'intuito di Fortunato da Cadore, poi ministro generale, che aprí al giovane religioso la via della cultura per lui tutt'altro che facile. Ricevuta l'ordinazione sacerdotale il 18 settembre 1655, cominciò subito, non senza qualche timore, l'apostolato della parola. Nel 1670 fu nominato superiore del convento di Belluno e, dopo due anni, di quello di Oderzo. Il peso della responsabilità ostacolava però il suo profondo desiderio di solitudine e di preghiera e pertanto i superiori, accogliendone la richiesta, lo trasferirono a Padova. Là un panegirico, che il servo di Dio dovette tenere per ubbidienza, lo rivelò al gran pubblico della dotta città, non tanto forse per l'eloquenza del dire, quanto per un fatto prodigioso. Cfr. Cassiano da Langasco, Marco d'Aviano in Bibliotheca Sanctorum,VIII, Roma 1967, col. 704-706. Il 27 aprile 2003 il S. Padre Giovanni Paolo II ha proclamato beato il p. Marco d'Aviano, additandolo alla Cristianità quale predicatore evangelico, eroico ed intrepido cappellano e testimone coraggioso di Cristo in ogni avversità.
B. Marco d'Aviano - Cappellano dell'Esercito Imperiale austriaco
Da quel momento ebbe inizio un intenso ritmo di vita che portò Marco sulle strade non solo del Veneto, ma di quasi tutta l'Europa. Queste predicazioni e questi viaggi furono contrassegnati dalla sempre crescente fama taumaturgica. Le numerose relazioni private e diplomatiche esaltano questa potenza; qualche voce discorde accenna anche a suggestioni e scene di fanatismo. A parte il giudizio sui singoli casi, che può richiedere uno spassionato esame critico, resta il fatto che Marco sfuggiva, per quanto possibile, gli onori e conduceva vita austera e di profonda pietà. Egli si valeva, per i suoi interventi a favore di bisognosi e malati, di una particolare formula di benedizione, che rimase famosa e gli creò qualche noia da parte delle autorità ecclesiastiche.
La fama oltrepassò i confini d'Italia, cominciarono a giungere richieste ai superiori e al papa per avere lo straordinario apostolo. Egli compí un primo viaggio nel 1680 visitando il Tirolo, la Baviera, Salisburgo e altre città austriache. Si recò quindi a Linz, dove era atteso dall'imperatore; vi si trattenne quindici giorni ed iniziò cosí quel rapporto tra Marco e Leopoldo I, che ebbe notevoli effetti sulla vita politica del tempo. L'imperatore, rimasto famoso per la lunga durata del suo governo (quarantasette anni) e per la complessità del carattere, trovò nel cappuccino il proprio confidente e consigliere, come dimostra la lunga corrispondenza intercorsa tra i due. Da Vienna Marco si trasferí a Neuburg, dove operò un grande prodigio.
Ritornato a Venezia, nella primavera successiva intraprese un nuovo viaggio per le Fiandre, attraverso la Francia. Con pretesti burocratici, ma in realtà per motivi politici, Luigi XIV non permise al cappuccino di passare per Parigi; anzi - e pare in malo modo - lo fece accompagnare alla frontiera. Compiuta la missione in Fiandra, ancora attraverso la Germania e la Svizzera, Marco ritornò in Italia, ma per breve tempo. Sollecitato da continue richieste da parte del re di Spagna, il papa avrebbe voluto che Marco si recasse in quella nazione. Avrebbe dovuto imbarcarsi a Genova, ma poiché soffriva il mare, gli si richiese un lasciapassare per la Francia meridionale, che Luigi XIV ostinatamente rifiutò.
Le vicende dei tempi ricondussero Marco a Vienna e lo prepararono al grande compito che caratterizza il secondo periodo della sua vita, la lotta contro i Turchi. Questi nella loro avanzata si erano spinti fin sotto Vienna alla quale avevano posto l'assedio. Marco, spinto dallo zelo e dalle vive raccomandazioni di Innocenzo XI, si portò al campo imperiale, vinse le riluttanze, appianò le divergenze, animò i soldati e soprattutto il coraggioso Giovanni Sobieski con l'incrollabile richiamo all'aiuto divino, e Vienna fu liberata (1683). Il servo di Dio, scrivendone al papa attestava che la liberazione era avvenuta «per miracolo». La vittoria la si sarebbe potuta sfruttare, inseguendo il nemico in fuga e liberando le altre città invase, ma la persistente rivalità tra i principi frustrò la felice occasione. Marco tuttavia continuò nella sua opera di persuasione, arrivando perfino a suggerire piani strategici.
Con la forza della volontà e con il prestigio riuscí a vedere la sconfitta definitiva dell'Islam in Europa con le battaglie di Budapest (1684-1686), Neuhäusel (1685), Mohacz (1687) e Belgrado (1688), fino alla pace di Karlowitz (1689). Nel 1684 era riuscito a far entrare nella Lega Santa anche Venezia e soleva dire che, se avesse potuto parlare con Luigi XIV, avrebbe convinto anche lui. Finite le campagne, il servo di Dio riprese instancabile la sua opera pastorale, richiamando le coscienze, combattendo il peccato, incitando alla pace e all'unione, rifuggendo dagli artifici della politica ufficiale, resistendo alle diffidenze, di cui si sentí fatto oggetto talvolta da parte della stessa diplomazia pontificia.
Nel 1699 si sobbarcò ad un ultimo viaggio a Vienna: «Non ne, posso piú - disse - ma il Papa comanda». Era affetto da un tumore che lo consumava. Il 25 luglio si mise a letto ed il 13 agosto morí, assistito dall'imperatore. Dopo solenni funerali, il suo corpo trovò riposo definitivo (1703 ) nella cripta dei Cappuccini di Vienna, accanto alle tombe imperiali. L'11 dicembre 1912, s. Pio X firmò il decreto d'introduzione della causa di beatificazione.
Di lui rimangono alcuni trattatelli ascetici, che godettero ai suoi tempi grande diffusione. Egli, di solito, viene raffigurato nell'atto di predicare. Il pittore polacco Matejko, in un quadro conservato nella Pinacoteca Vaticana, lo ha raffigurato a cavallo, dietro Giovanni Sobieski, nel trionfo dopo la liberazione di Vienna.
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
3:01 PM
0
commenti
![]()
Etichette: Marco Aviano
La liturgia nel solco della Tradizione
CITTÀ DEL VATICANO, giovedì, 13 settembre 2007 (ZENIT.org).- Pubblichiamo l’editoriale de “La Civiltà Cattolica”, apparso nel numero del 15 settembre 2007, in cui si analizza la Lettera apostolica Summorum Pontificum del 7 luglio 2007 con la quale Benedetto XVI ha consentito l’uso del Missale Romanum anteriore al Concilio, nell’edizione approvata da Giovanni XXIII nel 1962.
In una lettera accompagnatoria il Papa rassicura i “fratelli nell’Episcopato” sull’infondatezza dei timori che il provvedimento potrebbe suscitare. Infatti il Missale Romanum rinnovato da Paolo VI nel 1970 rimane la forma ordinaria della celebrazione eucaristica, mentre il Missale Romanum del 1962 potrà essere usato come forma straordinaria in favore di gruppi di fedeli ancora legati all’uso antico, che ne facciano richiesta.
Il documento pontificio, che entrerà in vigore il 14 settembre, Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, stabilisce le condizioni relative a tale uso.
LA LITURGIA NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE
Il 7 luglio 2007 è già passato alla storia quale data da cui non potrà prescindere né lo studioso dei riti che si occupa del cammino della riforma liturgica, né il pastore o il semplice fedele che si preoccupano della verità della celebrazione. Con un nuovo documento «sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970», reso pubblico in quella data, Benedetto XVI ha posto fine alle notizie che, seppure incerte, circolavano da tempo e che disponevano gli uni a «un’accettazione gioiosa», gli altri a «un’opposizione dura».
È lo stesso Pontefice a non far mistero di questi contrapposti sentimenti nei confronti di «un progetto il cui contenuto in realtà non era conosciuto». Adesso che lo conosciamo, lo vogliamo accogliere «con animo grato e fiducioso», certi che lo spirito della liturgia da tutti ricercato riuscirà a comporre in unità di vedute posizioni per il momento ancora distanti.
Prima di esaminare il contenuto del documento che Papa Benedetto presenta quale «frutto di lunghe riflessioni, di molteplici consultazioni e di preghiera», al fine di inquadrarlo nella sua giusta luce, sarà bene dare uno sguardo alla lettera accompagnatoria, dalla quale già abbiamo stralciato le espressioni citate. In essa il Vescovo di Roma, parlando — per così dire — col cuore in mano ai «fratelli nell’episcopato», esamina i due timori che si opponevano più direttamente alla pubblicazione del documento e ad ognuno di questi dà una circostanziata risposta.
Il primo timore è «che qui venga intaccata l’autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue decisioni essenziali — la riforma liturgica — venga messa in dubbio». A conferma dell’infondatezza di tale timore il Pontefice opera una distinzione importante, affermando che il Messale di Paolo VI «è e rimane la forma normale — la forma ordinaria — della liturgia eucaristica», mentre invece «l’ultima stesura del Missale Romanum, anteriore al Concilio, che è stata pubblicata con l’autorità di Papa Giovanni XXIII nel 1962 e utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere usata come forma straordinaria della celebrazione liturgica». Quindi il Pontefice si sofferma sui meriti del Messale del 1962. Precisa che «questo Messale non fu mai giuridicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre permesso». Ricorda che non pochi sono rimasti «fortemente legati a questo uso del rito romano che, fin dall’infanzia, era per loro diventato familiare», soprattutto «nei Paesi in cui il movimento liturgico aveva donato a molte persone una cospicua formazione liturgica». Tra costoro menziona in particolare coloro che, pur accettando il Vaticano II, «desideravano tuttavia anche ritrovare la forma, a loro cara, della sacra liturgia». Riconosce che in costoro «la fedeltà al Messale antico» si è configurata spesso come una comprensibile reazione «a deformazioni della liturgia al limite del sopportabile».
Dopo aver evocato le «deformazioni arbitrarie della liturgia» che purtroppo ci sono state, Benedetto XVI illustra l’opera del suo predecessore Giovanni Paolo II, che intervenne in due riprese. Anzitutto, già nel 1984 egli offrì ai vescovi diocesani, tramite la lettera Quattuor abhinc annos della Congregazione per il Culto Divino (cfr AAS 76 [1984] 1.088 s), la possibilità di concedere a quei sacerdoti che ne avessero fatto richiesta un indulto in favore del Messale del 1962. Quindi (cfr ivi, 80 [1988] 1.495-1.498) istituì con il motuproprio Ecclesia Dei adflicta del 2 luglio 1988 un’apposita Commissione, composta da un cardinale presidente e da altri membri della Curia romana, con lo scopo di facilitare la piena comunione di tutti coloro che si sentivano legati al Messale del 1962. Il motu proprio Summorum Pontificum si propone dunque di aggiornare e regolamentare quanto era stato avviato dai due provvedimenti anteriori, fra l’altro anche per «liberare i vescovi dal dover sempre di nuovo valutare come sia da rispondere alle diverse situazioni».
Il secondo timore era «che una più ampia possibilità dell’uso del Messale del 1962 avrebbe portato a disordini o addirittura a spaccature nelle comunità parrocchiali». Ma si tratta di un timore non realmente fondato. Infatti le condizioni presupposte per il suo utilizzo, vale a dire «una certa misura di formazione liturgica e un accesso alla lingua latina», fanno sì che il numero dei fedeli che faranno ricorso al Messale antico resti pur sempre esiguo rispetto a quanti continueranno a utilizzare il nuovo Messale.
Dopo aver rassicurato i destinatari della lettera, cioè i vescovi, circa l’infondatezza dei due timori, Benedetto XVI accenna a un possibile e vicendevole arricchimento tra «le due forme dell’uso del rito romano», in quanto l’una non potrà prescindere dall’altra. Se il Messale antico potrà e dovrà recepire dal nuovo, oltre all’inserimento dei nuovi santi e di alcuni nuovi prefazi, opportuni stimoli per una necessaria messa a punto delle «possibilità pratiche», cioè dell’assetto rubricale, d’altra parte nell’utilizzo del nuovo Messale «potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, quella sacralità che attrae molti all’antico uso».
Nel concludere la lettera accompagnatoria, il Pontefice precisa che la ragione positiva che lo «ha motivato ad aggiornare mediante questo motuproprio quello del 1988» è il desiderio di «giungere a una riconciliazione interna nel seno della Chiesa». Citando un testo paolino e facendo sua la franchezza con cui l’Apostolo contrappone al suo «cuore aperto» i «cuori stretti» dei corinzi (cfr 2 Cor 6,11-13), il Papa invita tutti ad aprire generosamente il cuore, per lasciar entrare, insieme alla convinzione che anche la liturgia cresce e progredisce, quella percezione del sacro dalla quale la liturgia stessa non può prescindere. Il messaggio è chiaro: se gli uni «non possono, in linea di principio, escludere la celebrazione secondo i libri nuovi», gli altri devono preoccuparsi di «conservare le ricchezze che sono cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa, e di dar loro il giusto posto».
Consapevole delle conseguenze liturgico-pastorali che potrà avere questo suo personale intervento, il Pontefice così si rivolge ai vescovi: «In conclusione, cari confratelli, mi sta a cuore sottolineare che queste nuove norme non diminuiscono in nessun modo la vostra autorità e responsabilità, né sulla liturgia né sulla pastorale dei vostri fedeli [...]. Inoltre, vi invito [...] a scrivere alla Santa Sede un resoconto sulle vostre esperienze, tre anni dopo l’entrata in vigore di questo motuproprio. Se veramente fossero venute alla luce serie difficoltà, potranno essere cercate vie per trovare rimedio».
Mentre la lettera accompagnatoria, grazie allo stile piano e trasparente con cui il Pontefice comunica le sue preoccupazioni di pastore supremo, favorisce una comprensione immediata, la parte giuridica del documento vero e proprio invece richiede un’analisi attenta del testo che dovrà essere letto «prouti iacet», e possibilmente nell’originale latino.
La prima parte del documento prende le mosse dal noto assioma patristico che regola il rapporto tra lex orandi e lex credendi. Letto nel contesto originario e nella formulazione peraltro sospesa dell’argomentazione di Prospero di Aquitania († 455) in favore della necessità della grazia, così suona l’assioma: «[...] affinché la normativa della preghiera determini la normativa della fede ([...] ut legem credendi lex statuat supplicandi)» (Denz.-Schönm. 246). Si può tuttavia notare che nel motuproprio, sulla base di una citazione tratta dalla Institutio generalis Missalis Romani e proveniente a sua volta dall’istruzione Varietates legitimæ (cfr AAS 87 [1995] 298 s) l’assioma è invertito.
Vi leggiamo: «Da tempo immemorabile, come pure per l’avvenire, si deve osservare il principio “per cui ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l’integrità della fede, perché la lex orandi della Chiesa corrisponde (respondet) alla sua lex credendi”» (Missale Romanum 20023, Institutio generalis, n. 397). Il rovesciamento qui operato è senz’altro legittimo, sia perché già lo si incontra nell’enciclica Mediator Dei di Pio XII (cfr AAS 39 [1947] 541), sia perché tra le due leges che presiedono al depositum fidei c’è sincronia e sintonia perfetta, né potrebbe l’una contrapporsi all’altra.
Nel documento, il Pontefice prosegue menzionando alcuni suoi Predecessori, particolarmente legati alla storia e agli sviluppi del Messale romano: san Gregorio Magno († 604), che si prodigò per arricchire la liturgia; san Pio V († 1572), che promosse l’edizione dei libri liturgici e principalmente del Messale emendato ad normam Patrum; Clemente VIII († 1605) e Urbano VIII († 1644), che ne curarono importanti revisioni; san Pio X († 1914), che tanto si impegnò per ripulire l’edificio liturgico «dallo squallore dell’invecchiamento» (AAS 5 [1913] 449 s); Benedetto XV († 1922), che pubblicò l’edizione rivista dal suo Predecessore; Pio XII († 1958), che volle il rinnovamento della veglia pasquale e della Settimana santa; il beato Giovanni XXIII († 1963), che ebbe il privilegio di aggiornare l’ultima edizione del Messale tridentino; Paolo VI († 1978), che seguì personalmente la riforma del Messale, nonché degli altri libri liturgici voluta dal Concilio; e infine Giovanni Paolo II († 2005), che ha legato il suo nome alla terza edizione tipica del Messale conciliare.
Dopo questa carrellata di Pontefici benemeriti e dopo un breve cenno ai problemi sollevati da parte di «non pochi fedeli» rimasti affezionati all’antico Messale e il ricordo degli interventi del suo immediato Predecessore in loro favore, Benedetto XVI affida la nuova normativa a una sequenza di dodici articoli. Li possiamo riassumere in maniera discorsiva nel modo seguente.
Esistono due soli usi del rito romano: la «forma ordinaria (ordinaria expressio)» con il Messale del 19701-20023 e la «forma straordinaria (extraordinaria expressio)» con il Messale del 1962 (art. 1). Nelle Messe senza concorso di popolo, ogni sacerdote di rito latino può usare liberamente il Messale del 1962 (art. 2). La precisazione «il sacerdote non ha bisogno di nessun permesso, né della Sede Apostolica né del suo ordinario» esprime un reale mutamento rispetto alla normativa in vigore dal 1984.
Allora si trattava di un «indulto», cioè di una concessione fatta — a titolo di deroga «indulgente» alla norma — dal vescovo diocesano a singoli sacerdoti e ai rispettivi fedeli, previa ammissione della legittimità ed esattezza dottrinale del Messale di Paolo VI. Ciò che prima era concessione, adesso è norma. L’uso del Messale del 1962 non è però consentito «nel Triduo sacro», perché in quei giorni la liturgia, da celebrarsi «cum fidelium frequentia» (Missale Romanum 20023, p. 298, sub 3), deve restare unica in una medesima chiesa. A queste celebrazioni possono essere ammessi anche quei fedeli che spontaneamente lo chiedono (art. 4). Con lo stesso Messale possono celebrare la Messa conventuale o «di comunità» tutte le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica (art. 3).
Nelle parrocchie in cui esiste «stabilmente (continenter)» un gruppo di fedeli affezionati alla precedente tradizione liturgica, il parroco è pregato di concedere volentieri ai sacerdoti «idonei» l’uso del Messale del 1962, però limitatamente a una sola celebrazione nelle domeniche e nelle feste; nessuna limitazione è invece espressa per le celebrazioni nei giorni feriali, come pure nel caso di matrimoni, esequie o pellegrinaggi (art. 5). La precisazione espressa dall’avverbio «continenter» esclude che la richiesta del «ritus antiquior» possa essere determinata da curiosità per il diverso, da ricerca di folklore religioso e — come si legge nella lettera accompagnatoria — da «aspetti sociali indebitamente vincolati all’attitudine dei fedeli». Invece la clausola «idonei esse debent» implica che i sacerdoti, oltre a conoscere bene il latino, dovranno avere un’adeguata familiarità con il «Ritus servandus in celebratione Missae» e analogamente con i rituali degli altri sacramenti.
Allorché si usa il Messale del 1962 nelle Messe con concorso di popolo, le letture possono essere fatte nella lingua vernacola, utilizzando i lezionari approvati (art. 6). I fedeli che, pur avendo chiesto al parroco l’uso del Messale del 1962, non lo avranno ottenuto, possono ricorrere al vescovo diocesano, che è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio; qualora poi non fosse in grado di esaudirlo, dovrà informarne la Commissione Pontificia Ecclesia Dei e attendere da questa consiglio e aiuto (art. 7-8).
In vista del bene delle anime, è lasciata: a) alla discrezione del parroco la possibilità di utilizzare il rituale più antico per il Battesimo, la Penitenza, il Matrimonio e l’Unzione degli infermi; b) alla discrezione del vescovo la scelta dell’antico Pontificale romano per la Confermazione; c) alla discrezione dei chierici ordinati la possibilità di usare il Breviario romano del 1962 (art. 9).
Dal fatto che nulla viene detto per il sacramento dell’Ordine si deve dedurre che l’unico rituale per le ordinazioni resta quello della riforma liturgica. In vista del bene dei fedeli affezionati al Messale del 1962, l’ordinario diocesano potrà erigere una parrocchia personale (art. 10). Infine, la Pontificia Commissione Ecclesia Dei, riconfermata nelle sue funzioni, dovrà vigilare sull’osservanza e l’applicazione di quanto è stato disposto (art. 11 e 12).
Il motu proprio conclude fissando al 14 settembre 2007 l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti, e abrogando di conseguenza, tramite la consueta clausola «contrariis quibuslibet rebus non obstantibus», tutte le precedenti determinazioni in materia.
[© La Civiltà Cattolica 2007 III 455-460 quaderno 3774]
Pubblicato da
Lega Antidiffamazione Cristiana
alle
2:17 PM
0
commenti
![]()
Etichette: liturgia tradizione motu proprio Pio V





